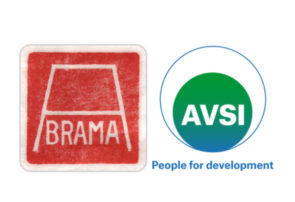Effetà – PLAN(T)OGETHER

INTRODUZIONE
 Le attività dei workshop proposti tendono allo sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni e stimolano ciascuno a ‘giocare’ integralmente sé stesso dentro la realtà circostante. La traccia di metodo che segue riprende il lavoro fatto lo scorso anno integrandolo di nuovi spunti, ed è stata condivisa – attraverso alcuni incontri preliminari – con sr Piera, direttrice di Effetà, fr Marwan, direttore del Terra Santa College for Boys e diverse insegnanti. Nella scuola di Effetà, abbiamo lavorato con i 15 ragazzi già incontrati lo scorso settembre (classi IX, X). Al Terra Santa College, i ragazzi coinvolti sono stati 12, di età compresa tra gli 11 e i 12 anni. Sinteticamente le attività svolte con i ragazzi dell’Istituto Effetà sono coincise con la realizzazione di un piccolo giardino all’interno del cortile della scuola. Il titolo di questo nuovo workshop è PLAN(T)OGETHER, perché l’aspetto del ‘seminare’ va di pari passo al ‘progettare’ insieme. La particolarità del nostro giardino è contenere oggetti di riuso, cose apparentemente senza valore a cui è stata data una seconda vita (lattine, copertoni, pallets…). Per i ragazzi del Terra Santa College sono state rielaborate e proposte le attività del workshop RE-DISCOVERING NATURE svolte l’anno scorso ad Effetà. Ci siamo quindi concentrati sull’osservazione e la scoperta di una bellezza che ci circonda, attraverso la visita ad un giardino e il laboratorio di disegno.
Le attività dei workshop proposti tendono allo sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni e stimolano ciascuno a ‘giocare’ integralmente sé stesso dentro la realtà circostante. La traccia di metodo che segue riprende il lavoro fatto lo scorso anno integrandolo di nuovi spunti, ed è stata condivisa – attraverso alcuni incontri preliminari – con sr Piera, direttrice di Effetà, fr Marwan, direttore del Terra Santa College for Boys e diverse insegnanti. Nella scuola di Effetà, abbiamo lavorato con i 15 ragazzi già incontrati lo scorso settembre (classi IX, X). Al Terra Santa College, i ragazzi coinvolti sono stati 12, di età compresa tra gli 11 e i 12 anni. Sinteticamente le attività svolte con i ragazzi dell’Istituto Effetà sono coincise con la realizzazione di un piccolo giardino all’interno del cortile della scuola. Il titolo di questo nuovo workshop è PLAN(T)OGETHER, perché l’aspetto del ‘seminare’ va di pari passo al ‘progettare’ insieme. La particolarità del nostro giardino è contenere oggetti di riuso, cose apparentemente senza valore a cui è stata data una seconda vita (lattine, copertoni, pallets…). Per i ragazzi del Terra Santa College sono state rielaborate e proposte le attività del workshop RE-DISCOVERING NATURE svolte l’anno scorso ad Effetà. Ci siamo quindi concentrati sull’osservazione e la scoperta di una bellezza che ci circonda, attraverso la visita ad un giardino e il laboratorio di disegno.
APPUNTI DI METODO
- Non possiamo ridurre l’educazione a una ‘trasmissione di conoscenze’, è innanzitutto un’esperienza in cui il ragazzo è accompagnato a divenire protagonista della propria vita. Questo percorso, attraverso cui il soggetto educato scopre il ‘proprio posto’ dentro la comunità, è caratterizzato da una serie di incontri che lo aiutano a comprendere il senso della realtà stessa e della propria personale consistenza.
- Questi incontri sono il materiale vivo con cui l’educatore lavora: favorendoli attraverso la lettura, la conoscenza della storia e dei luoghi, delle lingue, delle consuetudini, degli oggetti, vicini e lontani, della terra come delle stelle. In questi incontri l’educatore sollecita il soggetto educato ad un personale coinvolgimento così che egli possa sentirsi ‘degno di scoprire il mondo’[1].
- Oggi, nell’era della comunicazione globale e dell’immagine il viaggio di scoperta e di apprendimento è superfluo: per conoscere il mondo non sembrano più necessari né un contatto diretto, né qualcuno da seguire perché gli eventi e la realtà ci vengono “consegnati a domicilio”. ‘La guida, che prima ci indicava la via, ora impedisce la vista’[2].
- In questo contesto, di cui dobbiamo sempre più consapevolmente prendere coscienza, una delle opportunità per evitare la deriva utilitaristica dell’esperienza educativa è quella di ridare dignità all’evento dell’incontro e alle dinamiche in esso celate. L’incontro, che passi attraverso un volto o un oggetto, è sempre scoperta di sé, dell’io che fa della circostanza specifica l’occasione privilegiata per l’incontro col mistero che fa le cose (perché non le cose non le abbiamo fatte noi, e non si sono fatte da sé). Lo chiamiamo mistero perché la risposta alle domande “chi fa le cose? perché ci sono?” s’approfondisce: l’incontro con un mistero non si esaurisce e dargli un nome dipende dalla libertà di ciascuno.
- Le ‘cose’ del mondo, le pietre e gli esseri che popolano il mondo vegetale ed animale, acquistano, in questa prospettiva, una nuova dignità, una nuove luce: un nuovo statuto[3]. Sono presenza necessaria a che il mondo sia tale, perché continui ad essere nuovo ogni mattino, ed ogni momento ci chiamasse a ri-conoscerlo. Le cose ci mettono alla ricerca del senso e del significato di quello che accade.

- Noi vogliamo dare un contributo – in termini di ‘educazione ambientale’ – attraverso l’esperienza dell’incontro con alcuni protagonisti della realtà quotidiana: il mondo delle piante, degli arbusti, dei fiori e delle erbacee. Spesso silenziose, solitarie, marginali, trascurate, sono una presenza così forte che, se ci fermiamo per un attimo, ci rendiamo conto che definiscono il paesaggio che ci circonda e dentro il quale scorre la nostra giornata.
- Ci aiutiamo a riconoscerci ‘giardinieri’ di questo ‘giardino planetario’[4]: se il mondo è questo giardino in cui i paesaggi sono l’esito, continuamente in divenire, degli incontri, delle pause e dei vagabondaggi degli esseri viventi, allora per viverlo consapevolmente devo entrare in queste relazioni. E non posso entrare in relazione con qualcosa o qualcuno di cui non conosco il nome. Dato che ‘ciò che non ha nome non esiste’ il viaggio può cominciare dai nomi per scoprire poi tutto il resto.
- L’incontro con la natura come realtà data può portare ad una nuova consapevolezza, possiamo costruire il nostro vivere in rapporto con quello che c’è in modo più maturo, perché lo stupore e le domande che nascono sollecitano ad una scoperta sempre più profonda di noi: cosa ci colpisce? perché? dove possiamo ritrovare quella bellezza riconosciuta? come possiamo contribuire a costruirla? Ci interessa per questo indagare lo spazio dentro cui la natura attua le proprie dinamiche, coglierne il significato.
- L’uomo non può vivere senza modificare l’ambiente che lo circonda, lo abita cercando sempre di renderlo più corrispondente alle proprie aspirazioni. Come scriveva Le Corbusier: ”questa è la chiave… guardare, osservare, vedere, immaginare, creare”. Possiamo trasformare lo spazio e progettare qualcosa di nuovo a partire da quello ‘sguardo’ che abbiamo imparato. Indagando la relazione che una cosa ha con il resto, ne cogliamo il valore e possiamo cominciare ad averne cura, ne diventiamo in qualche modo responsabili.
[1] vedi A. FINKIELCRAUT, Un cuore intelligente, Adelphi Ed., 2011, p.102 e seg.
[2] ibidem
[3] vedi I. ÁBALOS, Atlas pintoresco, Editorial Gustavo Gili, 2005
[4] vedi G. CLEMENT, Il giardiniere planetario, 22 Publishing, 2008